INDICE

Premessa
Questo è un set di linee guida che orientino la scelta delle parole da utilizzare, nella vita personale, in azienda e professionale. Un set condiviso universalmente non esiste. Questo kit non è esaustivo e verrà aggiornato ogni qualvolta le mutazioni linguistiche lo renderanno necessario. La lingua, infatti, muta nel tempo e ciò rende necessario lo scouting continuo dei nuovi vocaboli e delle nuove riflessioni riguardanti un linguaggio che sia rispettoso di tutte le differenze. Di volta in volta verranno inserite nuove indicazioni e verranno modificate quelle già esistenti.
Partendo da alcuni principi generali che dovrebbero costituire le buone pratiche in ogni occasione e con qualsiasi persona, verranno poi dedicati capitoli specifici alle aree della disabilità, del genere, della galassia LGBTQIA+, dell’universo della multiculturalità, della fede e del culto religioso. Infine, volgeremo lo sguardo verso i nuovi orizzonti linguistici, che intendono superare il paradigma dell’inclusione per adottare un linguaggio ampio, ancora più adatto a rispettare ogni differenza.
L’obiettivo di queste linee guida è quello di offrire strumenti pratici per evitare di inciampare in stereotipi, generalizzazioni e discriminazioni.
Introduzione
Perché è necessario promuovere in modo esplicito, il cambiamento del linguaggio utilizzato in riferimento alle minoranze?
Il linguaggio muta continuamente in modo spontaneo, di pari passo con i cambiamenti della società. A tutte le persone viene spontaneo aggiungere nuovi termini al proprio vocabolario e smettere di utilizzarne altri che progressivamente vanno in disuso.
Le parole utilizzate, e gli atteggiamenti messi in atto nei confronti delle minoranze, sono talvolta esplicitamente aggressivi e di odio, ma in altri casi possono essere involontari o inconsapevoli atti linguistici che offendono o mantengono in vita stereotipi altrettanto negativi.
Potremmo utilizzare la metafora dell’iceberg, dove nella parte emersa , quella visibile, troviamo le fenomenologie esplicite di odio (hate speach), quelle su cui di solito vi è la consapevolezza di attaccare e ferire. Esiste poi ,il linguaggio quotidiano, quello che in modo inconsapevole e per lo più “benevolo”, veicola comunque stereotipi, etichette e pregiudizi, rinforzando retaggi e visioni desuete. È importante operare per aumentare la consapevolezza e far emergere questi “scivoloni linguistici”.
Come agire per ottenere questo risultato? È indispensabile uscire dal silenzio. Tutti noi, infatti, possiano essere agenti attivi, sia che un episodio ci riguardi direttamente, sia che si sia “solo” testimoni. Possiamo dare una mano, da alleati, per accelerare la presa di coscienza di come il benessere di tutti passi anche da atti linguistici apparentemente innocui.
Principi generali
Formazione delle parole e loro uso
Il lessico italiano comprende un repertorio consolidato di forme femminili, e una serie di neoformazioni, tra cui i termini femminili utilizzati per le professioni o per i ruoli istituzionali Tutte queste forme rispondono alle regole generali di formazione delle parole della lingua italiana e il loro uso è perfettamente legittimo.
Es.: la giudice, la preside, la dirigente, la docente, la presidente, la rappresentante, la capo dipartimento,
Termini o perifrasi che includano espressioni prive di referenza di genere: es. persona, essere, essere umano, individuo, soggetto.
Riformulazione con nomi collettivi o che si riferiscono al servizio o alla carica: es. personale dipendente, personale docente, magistratura, direzione, corpo docente, corpo insegnante, segreteria, presidenza, servizio di assistenza, utenza, consiglio, personale.
Riformulazione con pronomi relativi e indefiniti: es. chi / chiunque arrivi in ritardo.
Il genere grammaticale può essere “oscurato” anche attraverso strategie di tipo sintattico.
Uso della forma passiva, che permette di non esplicitare l’agente dell’azione,: es. “La domanda deve essere presentata” invece di “I cittadini e le cittadine devono presentare la domanda”.
Uso della forma impersonale: es. “Si entra uno alla volta” invece di “Gli utenti devono entrare uno alla volta”.
Rilevanza dell’informazione
Riferirsi all’identità di una persona, alla sua etnia o alla sua disabilità solo quando essa è rilevante per il discorso. Queste sono caratteristiche che andrebbero espresse esclusivamente se essenziali. come non si parlerebbe del colore dei capelli, a meno che l’informazione non fosse essenziale, Il principio è lo stesso adottato per altre caratteristiche come, ad esempio, il colore dei capelli o degli occhi: se l’informazione è rilevante e consente la comprensione, allora può essere utilizzata. In caso contrario essa può diventare caratterizzante in senso negativo. Basti pensare all’utilizzo escludente della parola disabile, o il riferimento al colore della pelle, all’etnia e all’appartenenza o meno alla comunità LGBTQIA+.
In generale, per quanto riguarda le identità LGBTQIA+ o le disabilità invisibili, è meglio non menzionarle a terzi senza l’esplicito permesso della persona interessata (Outing).
Libertà di autodefinirsi
Le persone appartenenti a una comunità possono usare i termini che preferiscono per riferirsi a loro stesse, anche se sono termini generalmente considerati offensivi. Nonostante l’accezione negativa di alcuni termini, ciascuno è libero di definirsi come preferisce. Ad esempio, non è inusuale tra gay, definirsi “froci”, ma è del tutto inopportuno che lo stesso termine venga usato da eterosessuali per definire persone appartenenti a quella comunità.
Attenzione al contesto
Un termine offensivo potrebbe venire usato come esempio di “parole da non utilizzare” come in questo documento o, in un prodotto di fiction, pronunciato da un personaggio negativo per evidenziare la sua crudeltà. Tuttavia, se il termine è considerato dalle comunità sottorappresentate come offensivo e discriminatorio, linguisticamente inappropriate e che contribuiscono a promuovere discriminazioni e pregiudizi, è importante non usarlo.
A to Z
Abilismo
Indica la discriminazione nei confronti delle persone fisicamente o mentalmente disabili, ma viene piú generalmente impiegato per stigmatizzare comportamenti che danno per scontata la norma e non tengono in debita considerazione i disabili. Vengono considerati abilisti tutti gli insulti che fanno riferimento a un disagio mentale o fisico.
Ageismo
Indica la discriminazione nei confronti delle persone anziane (o piú generalmente la discriminazione in funzione dell’età).
Agency
Capacità di agire in maniera autonoma, spesso limitata dalla condizione di subalternità.
Alleato
Si dice alleato di una minoranza qualcuno che, pur non appartenendole, ne appoggia attivamente le battaglie.
Blackface
Pratica con la quale negli Usa gli attori bianchi si dipingevano il volto di nero per interpretare gli afroadiscendenti in maniera caricaturale, il termine oggi definisce qualsiasi espediente per scurirsi la pelle al fine di imitare una persona nera. Per via delle memorie che risveglia nel contesto americano, la blackface è considerata profondamente offensiva anche alla periferia dell’Impero.
Body positivity
Sensibilità che promuove l’accettazione dei corpi non conformi.
Body shaming
Stigmatizzazione dell’aspetto fisico di una persona. A partire dal suffisso «shaming» (umiliare) esistono diverse varianti, a partire da fat-shaming, umiliazione a sfondo grasso-fobico.
Cisgender
Persona che si riconosce nel proprio sesso biologico, al contrario di una persona transgenere. Secondo alcuni attivisti, la condizione pur maggioritaria di maschio o femmina cis non dovrebbe essere data per scontata, ma precisata. La condizione maggioritaria di cisgender eterosessuale è detta cishet.
Color blind
Incapacità di notare le disuguaglianze legate al colore e alla razza.
Deadnaming
Menzione del vecchio nome anagrafico di una persona dopo che questa lo ha modificato in seguito a una transizione di genere. Considerato hate speech nelle policy delle principali piattaforme social.
Diversity management
Adozione di politiche inclusive nelle aziende.
Emancipazione
Liberazione dell’individuo o della minoranza dai rapporti di potere (es. razzismo e sessismo sistemico) che subisce.
Empowerment
Processo che porta una persona subalterna ad acquisire potere ed emanciparsi.
Hate speech (o linguaggio d’odio)
Etichetta che identifica quelle parole, frasi, immagini, simboli, gesti, ostili e offensivi, volti a causare danno a individui e gruppi storicamente oppressi e marginalizzati, identificati da caratteristiche sociali (reali o anche solo percepite) come etnia, nazionalità, religione, genere, orientamento sessuale, (dis)abilità. Si tratta della dimensione sociale dell’insulto e dell’odio: parole che scagliamo contro gli altri non per qualcosa che hanno fatto ma per qualcosa che sono.
Incel (involuntary celibate)
Maschio cishet respinto dal genere femminile, che sviluppa una ideologia maschilista e pessimista.
Interiorizzare
Assimilare inconsapevolmente un tratto ideologico. Es.
«misoginia interiorizzata».
Intersezionalità
Approccio che consiste nel prestare attenzione alla sovrapposizione di diverse identità per ottenere delle matrici di discri- minazione articolate.
Invisibilizzazione
Meccanismo sociale che occulta i problemi e le riven-
dicazioni di una minoranza (v.) Meccanismo simile è quello che consi-
ste nel silenziare.
Liberale
Nell’accezione woke indica un progressismo puramente for-
male, che rifiutando la prospettiva intersezionale (v.) non tiene contodei problemi specifici delle minoranze (v.) Es. «femminismo liberale». Piú generalmente va inteso come il contrario di radicale, ergo moderato.
Male gaze
Lo sguardo maschile, spesso sessualizzante, viene considerato come il punto di vista dominante.
Mansplaining
Propensione di alcuni uomini a manifestare un senso di superiorità sulle donne spiegando loro cose anche quando non le padroneggiano piú di tanto.
Micro-aggressioni
Comportamenti discriminatori di piccola portata, che facendo massa contribuiscono tuttavia a definire un contesto di esclusione.
Misgendering
Riferirsi a una persona con un genere diverso da quello in
cui si identifica è anche questo considerato hate speech.
N-word
La «parola con la n» è quella con cui negli Usa vengono chiamati i neri in maniera dispregiativa, e per estensione può indicare l’equivalente italiano. L’uso di questo giro di parole risponde alla convinzione che pronunciarla sia offensivo anche se contestualizzata come citazione.
Oggettificare
Considerare una persona come oggetto, negando la sua soggettività.
Patriarcato
In senso stretto, indica un sistema sociale arcaico fondato sulla prevalenza del padre, ma nell’attivismo contemporaneo serve a denunciare il privilegio associato alla condizione maschile.
Poliamoroso
Attrazione romantica o relazione consensuale tra piú di due persone, di qualunque sesso e genere. In quanto condizione estranea alla norma sessuale maggioritaria, viene considerata all’interno dello spettro LGBTQIA+ come non-monogamia etica.
Razza
Riferito agli esseri umani, il termine era caduto in disuso dapper- tutto tranne che negli Usa, dove è tornato di moda per indicare alcuni macro-gruppi caratterizzati dalla diversa pigmentazione della pelle e,
di conseguenza, da gradi differenti di privilegio.
Self-id
Principio secondo cui ogni persona dovrebbe poter stabilire in to- tale autonomia la propria identità di genere e godere degli effetti sociali annessi, senza ulteriori requisiti medici o legali.
Sessualizzare
Forma di oggettificazione (v.) che consiste nel sottolineare l’attrattività sessuale di una persona, attraverso rappresentazioni o discorsi, fuori dal contesto sessuale e senza il consenso.
Sex worker
Prostituta, prostituto, pornostar e simili.
Slur
Insulto o termine dispregiativo usato per denigrare un gruppo di persone sulla base di razza, genere, orientamento sessuale, religione, disabilità, ecc. Ad esempio, parole offensive usate per riferirsi a determinate etnie o categorie di persone sono considerate slurs.
Slutshaming
Stigmatizzazione del comportamento o dell’abbigliamento di una donna assimilandola a una prostituta.
Specismo
Calco di razzismo, indica la discriminazione nei confronti de- gli animali.
TERF
Termine dispregiativo con cui vengono definite alcune posizioni femministe (F), considerate radicali (R) e trans-escludenti (TE).
Tossico
Aggettivo che indica la natura asociale di un comportamento, ad esempio «mascolinità tossica».
Victim blaming
Stigmatizzazione del comportamento della vittima di una violenza o di un sopruso.
Violenza simbolica
Viene praticata attraverso il linguaggio o le micro- aggressioni.
White saviorism
Sindrome del salvatore bianco, indica una certa retorica ingenua sugli afrodiscendenti, che volendo essere progressista risul-ta invece irrimediabilmente paternalistica.
Woke
Il termine, con il quale in passato si autodefinivano gli attivisti stes- si, ha fatto in tempo ad assumere una connotazione dispregiativa e poi, per inversione dello stigma, nuovamente positiva. A ogni modo non sembra essercene uno piú neutro per definire la convergenza, mediata dall’attivismo digitale della generazione Z, tra le rivendicazioni delle minoranze e le istanze modernizzatrici del progressismo Usa, che oggi costituisce una delle punte di lancia dell’egemonia culturale americana.
Disabilità

Definizione
Parlando di disabilità ci riferiamo a caratteristiche fisiche, mentali, intellettive o sensoriali a lungo termine che, in interazione con barriere sociali e ambientali, possono ostacolare la piena eguaglianza fisica e sociale con il resto della società. In base a questa definizione, sono considerate disabilità anche le malattie mentali e le neurodivergenze. “Disabilità” è un termine neutro per riferirsi alla riduzione di funzione, attività o partecipazione di una persona, che deriva dall’interazione delle caratteristiche individuali con le caratteristiche dell’ambiente.
La disabilità può essere sia visibile che invisibile. Entra così in gioco il concettodi “passing”, termine che si riferisce al privilegio di apparire come una persona senza disabilità. Se da un lato il passing dà un privilegio sociale, significa anche spesso che le necessità di una persona senza disabilità visibili vengono sottovalutate o ignorate, o prese per false.
Un altro concetto da conoscere è quello di Temporally Abled Bodied (TAB). L’idea è che la disabilità sia un tema che riguarda tutte le persone, perché la maggior parte delle persone la vivranno, in qualche forma, nel corso della propria vita: magari invecchiando, o, temporaneamente, ammalandosi, rompendo un osso, affrontando un periodo particolarmente difficile per quanto riguarda la salute mentale.
La disabilità poi, non è sempre qualcosa di costante e permanente, ecco perché si parla anche di Disabilità Dinamiche, termine con cui si identificano quelle disabilità i cui sintomi possono manifestarsi in determinati periodi ed essere totalmente assenti in altri.
Definiamo come abilismo la discriminazione, il pregiudizio o la marginalizzazione delle persone con disabilità. Sotto il termine di abilismo rientrano sia le discriminazioni più palesi, come quelle a livello sistemico o i crimini d’odio, sia quelle più sottili e quotidiane, che implicano il trattare la persona con disabilità in modo diverso da come verrebbe trattata qualsiasi altra persona.
Indicazioni generali
È necessario evitare tre atteggiamenti nei confronti delle persone con disabilità.
- Il pietismo è un atteggiamento da evitare. Quando parliamo di pietismo, intendiamo la sfera di atteggiamenti che trattano la persona con disabilità come qualcuno per cui provare pena e pietà, o che tentano di evocare compassione nei suoi confronti.
- Il paternalismo è un atteggiamento da evitare. Esso considera la persona con disabilità come fondamentalmente incapace in ogni caso di decidere per sé stessa. Un chiaro esempio di paternalismo è l’abitudine a rivolgersi sempre a chi accompagna la persona con disabilità, invece che direttamente a lei.
- L’eroismo è un atteggiamento da evitare nei confronti della persona con disabilità. Quella dell’eroismo è un’altra retorica che ricorre molto frequentemente, e consiste nell’elevare le persone con disabilità a una figura eroica per azioni che, per qualsiasi altra persona, non sarebbero considerate straordinarie. Questo atteggiamento trova compimento nel cosiddetto.
Concetti essenziali
È opportuno distinguere tra due approcci:
- Person first: quando parliamo di person first, parliamo di un linguaggio che metta al primo posto la persona rispetto alla sua disabilità; diremo quindi, per esempio “persona con disabilità” invece che “persona disabile”, evitando di usare la disabilità come aggettivo.
- Identity first: quando parliamo di identity first, la disabilità non passa in secondo piano, in base all’idea che non debba essere necessario separare una persona dalla propria disabilità, dato che la disabilità stessa non è una caratteristica negativa, ma parte dell’identità di una persona. In questo caso diremo “persona disabile” invece che “persona con disabilità”.
Come regola generale, è sempre meglio chiedere alla persona con cui o di cui si sta parlando se preferisce che si usi linguaggio person first o identity first quando si parla con o di lei. Quando invece si è in dubbio, o si sta facendo un discorso generale, slegato dalla singola persona, è meglio usare linguaggio person first, tranne nel caso in cui si parli delle comunità autistica, cieca e sorda, che generalmente preferiscono l’identity first (quindi “persona autistica” invece che “persona con autismo”).
In sintesi
| Parole ed espressioni da evitare | Parole ed espressioni inclusive |
| Affetto/a/ə da, malato/a/ə di, portatore/ice di, che soffre di… | Persona con disabilità |
| Albino/a/ə; | Meglio utilizzare “una persona con albinismo” o “una persona albina”. |
| Anormale; evitare termini come questo che facciano riferimento a una “norma”. | Non esistendo una “norma” di riferimento, non esistono termini utilizzabili. |
| Audioleso/a/ə, sordomuto/a/ə, sordoparlante. | “Persona con disabilità uditiva” o sensoriale. In alternativa si può utilizzare “Persona sorda”. |
| Bisogni Educativi Speciali (BES) | “Studente/ssa/ə che ha bisogno di
accomodamenti”. Il termine “Bisogni educativi speciali”, largamente utilizzato a livello istituzionale, identifica la persona con disabilità come carente rispetto a una norma. Sono invece le istituzioni a essere carenti, in quanto non pienamente accessibili a ogni studente/ssa/ə. |
| Cerebroleso/a/ə. | Termine esclusivamente offensivo da non
utilizzare. |
| Costretto/a/ə in carrozzina/sedia a rotelle. | Evitare termini come questi che
associano gli ausili a qualcosa di negativo. Tutti gli ausili sono strumenti di liberazione e autonomia, e rappresentano uno dei tanti modi in cui si manifesta l’accessibilità. |
| Demente. | Termine esclusivamente offensivo, da non utilizzare. |
| Difetto/difetto di nascita. | Evitare termini come questi che inquadrino la disabilità come un difetto, facendo riferimento quindi a un’idea di eugenetica. Meglio utilizzare “persona con disabilità” o “persona con disabilità congenita”. |
| Disabile (un/una/unə disabile, utilizzato come sostantivo). | Meglio usare “persona con disabilità (person first) / una persona disabile” (identity first). Evitare di usare “disabile” come nome, perché è importante che le persone non vengano identificate con la loro disabilità, che è comunque una delle molteplici caratteristiche che la compongono e definiscono, non la prima e tanto meno l’unica. |
| Diversamente abile, con diverse abilità. | Espressioni considerate pietistiche o paternalistiche. Meglio usare “persona con disabilità”. |
| Down (un/una/unə down, utilizzato come nome). | Usare “persona con sindrome di down”. |
| Handicap, handicappato/a/ə, portatore/ice di handicap. | Termini superati. Utilizzare “disabilità” o “persona con disabilità”. |
| Inabile, invalido/a/ə. | Evitare termini come questi che inquadrino la disabilità come un difetto, facendo riferimento quindi a un’idea di eugenetica. Meglio utilizzare “persona con disabilità” o “persona con disabilità congenita”. |
| Mongoloide. | Termine offensivo, non utilizzare. |
| Nano/a/ə. | Seppure il termine “nano” venga rivendicato da alcune persone della comunità, esistono altre soluzioni preferite. Mutuatea dall’inglese si usa l’espressione “persona piccola” o “persona di bassa statura”, oppure seguendo la regola del person first“persona con nanismo”. In ogni caso preferibili alla parola “nano/a” meno di indicazioni precise della persona di cui o con cui si sta parlando. |
| Non udente/Non vedente | Meglio evitare di usare la negazione e invece utilizzare “persona sorda/cieca (es. Marco è cieco, non Marco il cieco), persona ipoacusica / ipovedente (a indicare sordità o cecità parziale)” (se preferiamo l’identity first) “persona con disabilità visiva/uditiva, persona con cecità/sordità” (se preferiamo il person first). |
| Normale, normodotato/a/ə. | Evitare termini che fanno riferimento ad una “norma”. Non esistono definizioni neutre volte ad evitare uno sbilanciamento o un giudizio (come ad es. per l’area LGBT+ dove l’alternativa a transgender è il cisgender), si usa “non disabile”. |
| Persona ad alto/basso funzionamento. | Termini usati spesso per descrivere persone autistiche, nella concezione che ci siano diversi “livelli di autismo”. In realtà l’autismo non è una linea retta da “più autistico” a “meno autistico”, ma è invece un insieme di tratti, ciascuno dei quali può manifestarsi ad intensità differente in ogni persona. I termini relativi al funzionamento differenziano tra persone autistiche “socialmente accettate” (i cui bisogni spesso non vengono perciò presi in considerazione, perché sono in grado di mascherare meglio i propri tratti neuro divergenti) e persone autistiche “meno socialmente accettabili” (e perciò discriminate maggiormente); si preferisce pertanto non utilizzarli, mantenendola definizione “persona autistica”. |
| Persona con autismo | La maggior parte delle persone della comunità autistica ha espresso la preferenza verso il linguaggio identity first, quindi “persona autistica”. |
| Rit*rdato/a/ə. | Termine considerato dalle comunità sottorappresentate come offensivo e discriminatorio –rientra tra le cosiddette espressioni “slur” (leggi capitolo sul Contesto) linguisticamente inappropriate e che contribuiscono a promuovere discriminazioni e pregiudizi. Non usare. |
| Ritardo mentale. | Utilizzare “disabilità intellettiva”. |
| Sciancato/a/ə (ed espressioni italiane e dialettali simili). | Termine esclusivamente offensivo, Non utilizzare. |
| Sordomuto/a/ə, sordoparlante. | Termini offensivi e datati. Utilizzare “sordo/a/” o “Persona sorda” al loro posto. |
| Sindrome di Asperger. | Il termine è stato tolto dal DSM-5 nel 2013 e sostituito con il termine generale “disturbi dello spettro autistico”. È considerato un termine negativo sia per la sua origine (Asperger era un medico nazista) sia per la sua accezione di differenziazione tra persone autistiche “più intelligenti” e “meno intelligenti”. |
| Sfigurato/a/ə, deforme. | Termini offensivi, da non utilizzare. Si può usare “disabilità corporea” o “disabilità legata all’aspetto fisico”. In alcuni casi entrano in uso espressioni mutuate dall’inglese come “persona con differenze facciali” o “persone con differenze corporee”. |
| Storpio/a/ə, zoppo/a/ə. | Termini esclusivamente offensivi,non utilizzare. Si può usare “persona disabile” (se si predilige l’identity first) o “persona con disabilità” (per il person first). Se ci si riferisce esclusivamente alla “disabilità motoria”, si può usare anche quest’ultima definizione specifica. |
| Videoleso/a/ə. | Meglio utilizzare “persona cieca” (se identity first) , o “persona con disabilità visiva” (se person first). |
Genere
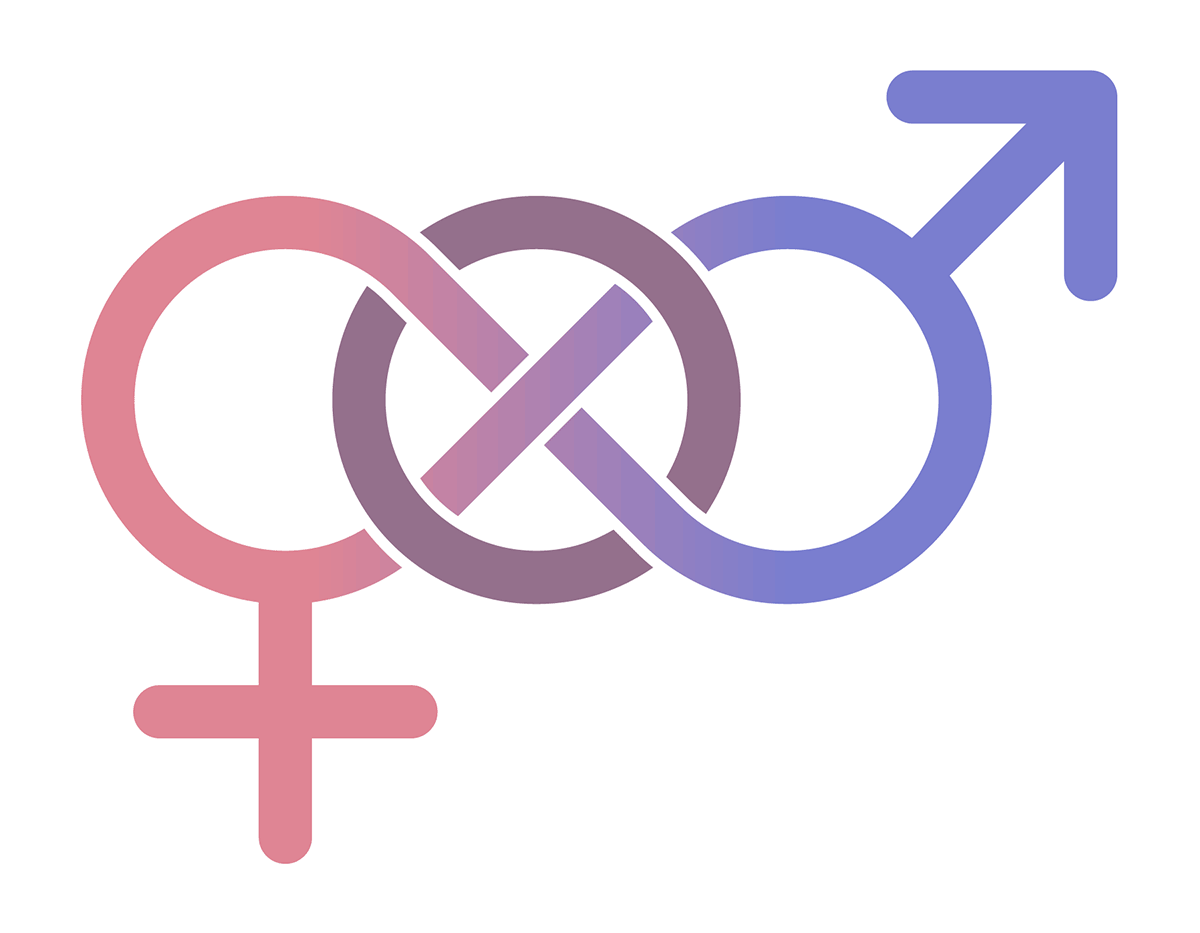
Definizione
Il meccanismo attraverso cui vengono prodotte e naturalizzate le nozioni di maschile e femminile. Una costruzione sociale mutabile nel tempo che determina le aspettative sui ruoli, funzioni e comportamenti caratteristici per ciascun genere. Quando parleremo di “genere” in questa istanza, faremo riferimento al modo in cui il linguaggio può perpetuare e rinforzare la gerarchia tra i generi binari in funzione dei ruoli sociali, economici e politici attribuiti al femminile e al maschile.
L’identità di genere si riferisce al genere in cui una persona si identifica e può coincidere o meno con il suo sesso biologico.
Concetti essenziali
Femminicidio – Qualsiasi omicidio di una donna che abbia motivazioni, anche implicite, legate al suo genere e a pregiudizi e concezioni sistemiche e patriarcali. Non si riferisce quindi a qualsiasi omicidio di persone di genere femminile, ma solo a quelli che sono legati alla discriminazione di genere. Include non solo gli omicidi commessi da partner o ex partner, ma anche quelli perpetrati da membri della famiglia o estranei motivati dalla cultura di sopraffazione verso il genere femminile.
Femminismo – Movimento diretto a eliminare la discriminazione di genere e a portare equità tra i diversi generi, a livello interpersonale, sociale, economico, politico e sistemico. Non si tratta quindi di un movimento per la superiorità della donna, ma di una corrente mirata a contrastare le discriminazioni e le gerarchie di potere tra i generi, puntando alla giustizia sociale e rispetto dei diritti umani. I movimenti femministi hanno importanza storica nell’avanzo dei diritti civili in senso ampio. Negli ultimi decenni i movimenti si sono estesi ad altre tematiche che si intrecciano alla questione femminile come il Femminismo Nero, Ecofemminismo, Transfemminismo e altri.
Mascolinità tossica – Insieme di comportamenti e caratteristiche ritenuti necessari per essere riconosciuti come “veri uomini”, in riferimento a norme e ruoli di genere. Legati a un’idea di virilità performativa, hanno un forte impatto sia sulla società che sulle persone, e puntano sulla soppressione di emotività, femminilità, sensibilità e di qualsiasi cosa possa essere vista come una debolezza.
Norme e ruoli di genere – Serie di norme comportamentali culturali prestabilite per ogni genere, con un set di “ruoli” fissi sociali previsti per donne e uomini. Si tratta di una serie di comportamenti, percorsi di vita e atteggiamenti che ci si aspetta a seconda del genere, uscendo dai quali si rischia di incorrere in discriminazione ed emarginazione.
Vittimizzazione secondaria – Una condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio psicologico e sociale agito sulla vittima di violenza. La vittimizzazione secondaria cerca di responsabilizzare la vittima per la violenza subita suggerendo un atteggiamento di insufficiente attenzione verso l’aggressore o additando a comportamenti della vittima la causa della violenza. Nel linguaggio si presenta con l’utilizzo di espressioni che collocano la vittima come soggetto: “si l’è cercata”, “l’ha portato all’esaurimento”, “l’ha lasciato”.
Lessico dell’identità sessuale
In sintesi
| Parole ed espressioni da evitare | Parole ed espressioni inclusive |
| Avere le palle. | Espressione basata sull’associazione virilità/forza con gli organi genitali maschili. Preferibile utilizzare coraggio, audacia, determinazione. |
| Bagascia, baldracca, battona, squillo, troia, zoccola, puttana. | Espressioni offensive per riferirsi alle sex workers o associare una donna a un’idea di sex working. |
| Cagna. | Espressione disumanizzante collegata al comportamento sessuale. |
| Chi dice donna dice danno. | Associazione della donna a un’idea di incompetenza. Evitare luoghi comuni che tramandano stereotipi. |
| Cougar. | Termine basato sul pregiudizio verso le donne, generalmente dai 40 anni in su, che hanno relazioni sessuali/romantiche con partner molto più giovani. Evitare di descrivere una persona in base alle relazioni romantiche/sessuali che intraprendono. |
| Donna al volante pericolo costante. | Associazione della donna a un’idea di incompetenza. Evitare luoghi comuni che tramandano stereotipi. |
| Essere una femminuccia. | Espressione spesso direzionata a bambini/ragazzi che giudica l’espressione della sensibilità maschile e riconduce la femminilità alla debolezza. Evitare pregiudizi sull’espressione della
sensibilità maschile. |
| Fatalona. | Come molte parole che fanno riferimento alla bellezza delle donne, nasconde una concezione di seduzione come arma femminile, all’interno di una
cultura che vede come unici poteri della donna quelli legati alla sessualità e alla maternità. |
| Femminismo bianco. | Attivismo disattento alle istanze delle minoranze ed eventualmente alle disuguaglianze di classe. |
| Figa. | Espressione sessualizzante, che collega l’aspetto estetico di una donna al suo organo sessuale. Fare attenzione poiché si tratta di una espressione sensibile. |
| Figlio/a/ə di buona donna. | Offesa basata sull’associazione della madre al sex working. |
| Frigida. | Offesa basata sul comportamento sessuale. |
| Gallina. | Espressione offensiva, che riduce la donna a un animale in relazione a un comportamento visto come frivolo o a un’espressione libera dei propri sentimenti. |
| Gnocca. | Espressione sessualizzante, che collega l’aspetto estetico di una donna al suo organo sessuale. Fare attenzione poiché si tratta di una espressione sensibile. |
| Mammo. | Espressione utilizzata per riferirsi a un uomo che prende cura dei propri figli. Utilizzare la parola padre. |
| Maiala. | Espressione disumanizzante collegata al comportamento sessuale. |
| Oca. | Espressione offensiva, che riduce la donna a un animale in relazione a un comportamento visto come frivolo o mirato alla seduzione, in una cultura che punisce la donna se prende l’iniziativa in ambito romantico o sessuale. |
| Porca. | Espressione disumanizzante collegata al comportamento sessuale. |
| Portare i pantaloni. | Espressione che collega la figura che prende le decisioni in un rapporto ai codici di genere maschili, basata sull’associazione virilità/forza. Preferibile utilizzare persona che decide. |
| Racchia. | Espressione che rientra nel campo del body-shaming. |
| Scrofa. | Espressione disumanizzante. |
| Signorina. | Termine sminuente e riferito allo stato civile. Il suo corrispettivo maschile, “signorino”, è riconosciuto come infantilizzante, e non viene pertanto usato, a differenza della versione femminile. Utilizzare il cognome e/o il ruolo lavorativo. |
| Vacca. | Espressione disumanizzante collegata al comportamento sessuale. |
| Zozza, zozzona. | Offesa basata sul comportamento sessuale. |
LGBTQIA+

Definizione
LGBTQIA+ è l’acronimo che rappresenta l’insieme delle persone Lesbiche lesbiche, Gay, Bisesessuali, Transgender, Queer, Intersessuali, Asessuali e tutte le altre persone che non si identificano eterosessuali.
Indicazioni generali
Quando si parla di comunità LGBTQIA+, non utilizzare le etichette relative alla comunità come sostantivi, ma come aggettivi. Per esempio, non si dirà “un gay” o “un transgender”, ma “un uomo gay”, “una persona transgender”, “una donna lesbica” e così via.
Rivolgendosi a gruppi di persone è importante utilizzare un linguaggio in cui possano riconoscersi anche persone non binarie. Per esempio, frasi come “signori e signore, benvenuti” possono risultare escludenti verso chi non si identifica in nessuno di questi due termini; è consigliato, pertanto, di usare perifrasi come “un benvenuto a tutte le persone in sala”. Nel parlare di persone non binarie è inoltre possibile implementare soluzioni che permettano di superare il binarismo di genere della lingua italiana, con declinazioni diverse a seconda dei canali:
Nello scritto, è possibile utilizzare asterischi, schwa, x, o troncare le parole: “bell*, bellə, bellx, bell-”. Nel parlato, è possibile utilizzare desinenze in –u, troncare le parole o fare perifrasi: “bellu, bell-, di bell’aspetto”.
È essenziale tenere in conto il canale di comunicazione, il target, la questione dell’accessibilità (alcune soluzioni, come l’asterisco, possono essere di difficile interpretazione per i lettori automatici) e soprattutto i desideri e le indicazioni della persona di cui si sta parlando.
Concetti essenziali
Sesso – Combinazione dei tratti anatomici, morfologici e fisiologici che determinano e distinguono individui di una stessa specie. Il sesso viene sessuale non dipendono l’uno dagli altri. assegnato alla nascita in base all’anatomia. Sesso, genere e orientamento
Genere è Il meccanismo attraverso cui vengono prodotte e naturalizzate le nozioni di maschile e femminile. Una costruzione sociale, mutabile nel tempo, che determina le aspettative sui ruoli, funzioni e comportamenti caratteristici per ciascun genere.
Identità di genere – Senso di appartenenza di ogni individuo al genere in cui si identifica. Il genere può coincidere con il sesso assegnato alla nascita, e in tal caso la persona si definirà cisgender; o può differire da esso, e in tal caso la persona si definirà transgender. Molte persone si identificano in uno dei due generi binari (uomo o donna), altre no (nonbinary, genderqueer, genderfluid ecc). A differenza dell’espressione di genere, il genere non è visibile.
Orientamento sessuale – Attrazione fisica e/o sessuale di una persona verso altri individui, ad esempio del suo stesso genere (omosessualità), del genere opposto (eterosessualità), di due o più generi (bisessualità), di tutti i generi (pansessualità). La mancanza o rarità di attrazione sessuale viene definita asessualità. L’orientamento può variare in maniera e in gradi differenti durante il corso della propria vita.
Espressione di genere – Insieme di apparenze, presentazione esterna e comportamento di una persona, socialmente associati a un genere. Nome, pronomi, vestiti, taglio di capelli e modo di parlare sono tutti aspetti dell’espressione di genere. L’espressione di genere e il genere non devono per forza coincidere; per esempio, un uomo potrebbe avere un’espressione di genere femminile, e allo stesso modo una persona non binaria non deve per forza presentarsi come androgina.
Coming out / outing – termini vengono spesso confusi tra loro. Il “coming out” è l’atto volontario di una persona di rivelare il proprio orientamento sessuale e/o romantico, il suo essere transgender, o in generale la propria appartenenza alla comunità LGBT+. L’“outing” è invece il rivelare l’appartenenza di una persona alla comunità LGBT+ senza il suo consenso.
Omofobia, bifobia, transfobia – Omofobia, bifobia e transfobia indicano rispettivamente il pregiudizio e la discriminazione verso le persone omosessuali, bisessuali e transgender. Non sono gli unici tipi di discriminazione che colpiscono la comunità LGBT+; ogni lettera dell’acronimo subisce discriminazione.
Lessico dell’identità sessuale
In sintesi
| Parole ed espressioni da evitare | Parole ed espressioni inclusive |
| Amico/a/ə (quando rivolto al/alla/allə compagno/a/ə di una persona LGBTQIA+ in una relazione con una persona del suo stesso genere). | Il termine amico/a/ə a volte viene utilizzato al posto di “ragazzo/a/ə, compagno/a/ə, fidanzato/a/ə, marito/ moglie” per evitare di ammettere una chiara e dichiarata relazione tra due persone dello stesso genere. Questo uso è scorretto perché non rispetta la dignità delle persone in relazione, sminuendo il loro legame e svelando un pregiudizio nei loro confronti. Chiaramente, questa indicazione vale per le coppie che sono out, ossia dichiarate come tali: se la coppia non fosse out, attenzione ad evitare un fenomeno di outing. |
| Bisex. | Meglio utilizzare “bisessuale”. |
| Cambio di sesso. | Meglio utilizzare “Transizione”. Le transizioni sono percorsi articolati e diversi per ciascuna persona transgender; definirle “cambio di sesso” può essere riduttivo o inadeguato. |
| Dell’altra parrocchia/sponda. | Usare invece l’orientamento sessuale o romantico della persona di cui si sta parlando. Ad es. “gay, lesbica…”. |
| Diventata donna / diventato uomo. | Espressioni spesso utilizzate per indicare una donna o un uomo transgender. Il genere di una persona transgender è indipendente dal suo aspetto fisico: una donna transgender è una donna a prescindere dalla sua biologia. Pertanto, anche se sceglie di fare una transizione, non passa da essere uomo a essere donna: è sempre stata donna. Al posto di questa espressione si può dire che una persona è “transgender” o che “ha effettuato un percorso di transizione”. |
| Ermafrodita. | Termine utilizzato erroneamente per riferirsi a persone intersex, ovvero quelle persone in cui i cromosomi sessuali e/o i caratteri sessuali primari o secondari non sono definibili come strettamente maschili o femminili, o per riferirsi a persone bisessuali. Utilizzare al suo posto le parole “intersex/ intersessuale” o “bisessuale”, a seconda del contesto. |
| Fare outing. | Fare attenzione a non confondere “fare coming out” (l’atto volontario di una persona di rivelare la propria appartenenza alla comunità LGBTQIA+) e “fare outing” (l’atto di rivelare l’appartenenza di un’altra persona alla comunità LGBTQIA+, senza il suo consenso). |
| Frocio e sue alternative, bardassa, bardascia, bucaiolo, buliccio, buso, busone, buggerone, cula, culattone, cupio, recchia, recchione, ricchione, sfranta, checca, finocchio, frocio, invertito etc… | L’uso di questi termini è offensivo. Si dovrebbe utilizzare la parola “gay”, non in forma di insulto. Parole come “frocio” e simili, sono altresì reclamate dalla comunità LGBTQIA+ e il loro uso non è considerato offensivo quando a farlo sono persone appartenenti alla stessa
comunità. Infine, le parole “lesbica” e “gay”, reclamate come identitarie, vanno usate come definizioni, non come insulti. |
| Gay pride. | Il PRIDE è un momento di orgoglio e rivendicazione per tutta la comunità LGBTQIA+, non soltanto per la comunità gay. È pertanto preferibile la dicitura “Pride”. |
| Utero in affitto | Si tratta della pratica in cui una donna accetta di portare a termine una gravidanza al posto di qualcun altro. Questa donna è chiamata portatrice (o madre surrogata). La fecondazione avviene in vitro: lo sperma proviene da uno dei due aspiranti papà, mentre l’ovulo può appartenere alla portatrice (ma è un caso più raro) oppure a una
donatrice. Utilizzare “Maternità surrogata”, “Gestazione per altri” o “Gestazione di sostegno”. |
| Relazioni dello stesso sesso. | A meno che non si parli di requisiti legali (ad es. per unioni civili) è meglioutilizzare “relazioni dello stesso genere”, per includere anche le relazioni queer in cui una delle due persone è transgender: in quella circostanza, le due persone non saranno dello stesso sesso, ma saranno dello stesso genere. |
| Transessuale, travone, travione, Travestito/a/ə. | Termine più datato per “transgender”, tendenzialmente collegato a un’idea di transizione medica. Anche se alcune persone ancora si identificano in questo termine, si preferisce generalmenteutilizzare “transgender” al suo posto. Se ci si vuole riferire a una persona transgender, allora utilizzare il termine
“transgender”. Se in riferimento a una persona “crossdresser “(persona che si veste con indumenti associati a un genere diverso dal suo) o a una “drag queen”, allora utilizzare questi due termini. |
| Velato/a/ə. | Termine che si riferisce ad esempio, a una persona che, nonostante si definisca bisessuale, si ritiene essere gay; oppure ad una persona lesbica/gay/queer in genere che non ha fatto coming out. Siccome l’identità di una persona non dovrebbe essere messa in discussione, è meglio evitare questo termine. |
Etnia

Definizione
Il termine “etnia” si riferisce a una comunità caratterizzata da omogeneità di lingua, cultura, tradizioni e ricordi storici. I componenti della medesima etnia, spesso, sono anche accomunati dalla permanenza in un determinato territorio.
Indicazioni generali
Non generalizzare le soggettività che incontriamo. Davanti a un qualsiasi soggetto i cui tratti somatici ci ricordano concetti o immagini che conosciamo evitiamo di semplificarne origini e identità dando per scontato il suo background (es. Ci sono persone con tratti somatici asiatici di origine tedesca; persone con un “aspetto europeo” che possono essere sudamericane e altre con caratteristiche pigramente definibili come straniere che sono state adottate etc..).
Restare in ascolto delle diverse e specifiche identità. L’esperienza italiana di persone con background migratorio risulta sfaccettata e in continua trasformazione. Per evitare di incappare in errori di definizione l’indicazione migliore è domandare al soggetto interessato come preferisce definirsi (es. una persona Nera può decidere di definirsi in molti modi: afrodiscendente, italo-ghanese, afroitaliana ec..)
Nel momento in cui incontriamo soggetti razzializzati, non conoscendo il loro background e il loro livello di conoscenza della lingua italiana, è bene sempre fare attenzione a imbastire una conversazione accessibile e chiara. Spesso persone con background migratorio non conoscono la lingua italiana, ma sono a conoscenza di altre lingue (a volte più di una). Evitando di sminuire o schernire un soggetto per la mancanza di proprietà linguistica di una lingua riusciremo ad entrarci in contatto con un’interazione paritaria.
Concetti essenziali
Razza – In alcune lingue, viene utilizzato sempre meno poiché fa riferimento alla teoria razzista secondo cui i tratti soggettivi identitari erano determinati unicamente dalle caratteristiche fisiche e somatiche. Dal punto di vista biologico e scientifico, le razze non esistono, ma come affermato da Angela Davis, dal punto di vista politico e sociale le razze persistono e comportano delle esperienze di vita diverse a seconda dei soggetti.
Razzializzazione – Termine utilizzato, facendo riferimento al processo attraverso il quale un gruppo dominante attribuisce caratteristiche discriminatorie a un gruppo emarginato.
Razzializzato – Termine che consente di identificare il processo di “costruzione sociale” delle razze nel mondo di oggi ponendo l’attenzione sull’impatto che questi costrutti hanno nonostante l’assenza di riferimenti biologici.
“Bianchezza” – Costrutto sociale che va oltre il colore della pelle, implicando privilegi e aspettative sociali associati al gruppo dominante, che spesso include ideali di bellezza, efficienza e razionalità. Questo concetto funge da norma con cui valutare le altre identità e influisce sulle dinamiche sociali e sulle opportunità all’interno della società.
Razzismo Individuale – Il razzismo a livello individuale comprende azioni dirette, sia offline che online, che prendono di mira una persona di diversa origine etnica culturale e che esprimono intenzionalmente pregiudizi, odio o bias basati su queste differenze.
Razzismo culturale – Il razzismo biologico è la teoria pseudoscientifica, diffusa nell’Ottocento e successivamente smentita, che associa diverse razze a specifiche caratteristiche come intelligenza, progresso, etc. Il razzismo culturale, invece, stabilisce una simile correlazione tra caratteristiche “innate” e appartenenza culturale. Questo tipo di discriminazione, per esempio, è emerso in maniera particolarmente violenta nelle ultime due decadi nei confronti delle persone di origine araba e di fede musulmana (islamofobia). Esso si alimenta di stereotipi, pregiudizi, voci e narrazioni, contribuendo a rafforzarli.
Razzismo storico – Ampiamente diffuso in Italia, deriva dall’ignoranza o dal rifiuto di riconoscere e analizzare fatti storici legati al razzismo, come il colonialismo italiano in Africa. Avvenimenti che comportano conseguenze ancora radicate nella cultura odierna. È spesso associato alla nota e auto-assolvente frase “italiani brava gente”. Questa forma di razzismo non si limita ai crimini del passato, ma svolge un ruolo di giustificazione continua che serve a proteggere l’innocenza delle persone non razzializzate rispetto alle ingiustizie storiche che continuano a influenzare le relazioni tra le regioni globali del nord e del sud e tra individui con e senza esperienze di razzismo.
Razzismo sistemico – Indipendentemente da comportamenti individuali o leggi esplicitamente discriminatorie, esistono condizioni sistemiche di svantaggio che colpiscono specifici gruppi sociali. Queste forme di esclusione si sono radicate nel corso della storia e sono diventate parte accettata del “normale,” spesso senza essere notate o contestate. Ad esempio, le sfide che le persone non razzializzate affrontano nel trovare una casa o un lavoro derivano da una complessa combinazione di fattori, tra cui comportamenti individuali, pregiudizi impliciti, diffidenza, razzismo culturale, leggi penalizzanti, e il fenomeno del colorismo. Il risultato del razzismo strutturale o sistemico si riflette in tassi sistematicamente inferiori di occupazione, istruzione, avanzamento professionale e altro.
Stereotipi – La definizione della nostra identità passa attraverso l’appartenenza a gruppi sociali. Le convinzioni collegate al gruppo sociale di appartenenza, e quindi al proprio background, sono tra le più difficili da scardinare appunto perché strettamente collegate alla costruzione della nostra identità. Per questo possono essere uno dei serbatoi più inesauribili di pregiudizio verso le altre persone, ossia chi non riteniamo appartenere al nostro gruppo ed avere un background simile. L’etnia, così come il colore della pelle, sono un’informazione che leghiamo a questo concetto. Tendiamo a preferire chi ci somiglia, principalmente perché ci fa meno paura e riteniamo sia più semplice capirsi. Questo effetto si manifesta nei contesti più svariati, dalle conoscenze private ai personaggi pubblici, ai colloqui di lavoro. Una delle conseguenze più importanti è che tendiamo anche a fidarci di chi riteniamo sia più simile a noi, e in ambito professionale, ad esempio, le scelte e i giudizi che noi riteniamo razionali perché legati a un giudizio logico, sono invece collegati a questo bias. Ed è evidente che maggiore è la distanza reale o percepita dalla persona che ci troviamo di fronte, maggiore sarà la nostra tendenza a rifugiarci nella nostra identità e a guardare l’altra persona attraverso la lente dello stereotipo. È quello che succede, ad esempio, ogni volta che una persona nata e cresciuta in Italia, ma con tratti non caucasici, si sente rivolgere la domanda “di dove sei?”. Le parole, il modo di definire e costruire una cornice che rappresenti l’identità di una persona e il suo background, sono fondamentali nella lettura e comprensione della rappresentazione etnica.
In sintesi
| Parole ed espressioni da evitare | Parole ed espressioni inclusive |
| Baluba. | Utilizzare solamente in riferimento al gruppo etnico africano e non come termine svalutante. |
| Bangla. | È preferibile non utilizzare abbreviazioni, perché possono essere considerate offensive. Evitarne l’uso, se non si è parte della comunità, preferire “persona del Bangladesh”. |
| Beduino/a/ə. | Parola spesso usata in riferimento a qualcuno dall’apparenza trasandata o sporca. Non utilizzare. |
| Berbero/a/ə. | Il termine ha una connotazione negativa, deriva da “barbaro”. Al suo posto usare Amazigh. |
| Clandestino/a/ə. | L’espressione rinforza stereotipi negativi. Usare eventualmente “migrante”. |
| Cineseria. | L’espressione da evitare perché rinforza stereotipi negativi. |
| Di colore. | L’espressione rimanda a uno sguardo
eurocentrico e biancocentrico dove la bianchezza è considerata la norma e la normalità. Quando si parla di persone nere è meglio usare il termine “nero”, “nera” o “nerə” al suo posto, se ci si vuole riferire a persone non bianche in generale si può utilizzare il termine “razzializzate”. Ancora più neutra è la parola “afrodiscentente” |
| Eschimese. | Utilizzare “Inuit, Yupik”. |
| Essere nero/a/ə di rabbia. | Meglio utilizzare “Essere molto arrabbiato/a/ə, essere rosso di rabbia” ecc. |
| Extracomunitario/a/ə. | Questo termine ha una forte connotazione negativa; non verrebbe mai usato in relazione a una persona francese, o americana. Usare l’area geografica di provenienza o la nazionalità. |
| Fumare come un turco, lavorare come un nero/neg*o, etc… | Espressioni che rinforzano stereotipi negativi. Evitarne l’utilizzo. |
| Giudeo/a/ə. | Termine con connotazioni antisemite. Usare “appartenente alla comunità ebraica” o “ebreo/a/ə”.\ |
| Indiani d’America. | Termine obsoleto e derogatorio. Usare “Nativo Americano/a/ə”. |
| Islamico/a/ə. | Termine che non va usato per indicare delle persone, ma è riferito alle cose. |
| L’uomo nero. | Termine dalle connotazioni negative. Non utilizzare. |
| Meticcio/a/ə, mulatto/a/ə. | Termini offensivi o dalle connotazioni negative. Se l’intenzione è quella di descrivere “persone di etnie miste”, si può usare quest’ultima descrizione mutuata dall’inglese “mixed people” |
| Muso giallo. | Termine offensivo. Non utilizzare. |
| Neg*o/a/ə e derivati come
ù neg*etto/a/ə. |
Termine altamente offensivo. Non utilizzare.
Questa parola è considerata una slur, ovvero una parola offensiva dai connotati storici, sociali e culturali profondamente negativi e di matrice razzista, colonialista e schiavista. Dopo secoli di discriminazione che ancora persiste – secoli in cui questa parola è stata usata in senso eugenetico per perpetuare crimini d’odio – il termine può causare forti emozioni negative in chi d’abitudine se la sente rivolgere come un insulto, o è semplicemente consapevole dei suoi significati e rimandi extralinguistici. In generale, dato il retaggio e la realtà corrente del termine, utilizzarlo significa proseguire la sua storia di discriminazione e white supremacy. Da indicazioni precise della comunità nera, pertanto, non esiste circostanza in cui una persona non nera possa usare questa parola. Quando si parla di persone nere è meglio usare il termine “nero/a/ə”. |
| Nomade. | Termine offensivo. Non utilizzare. |
| Paki. | È preferibile non utilizzare abbreviazioni, perché possono essere considerate offensive. Evitare l’uso se non si è parte della comunità pakistana. Dire invece“persona del Pakistan”. |
| Pellerossa. | Termine obsoleto e derogatorio. Usare “Nativo Americano/a/ə”. |
| Razza. | Il termine viene utilizzato sempre meno poiché fa riferimento alla teoria razzista secondo cui i tratti soggettivi identitari erano determinati unicamente dalle caratteristiche fisiche e somatiche. Da evitare, utilizzare eventualmente “etnia”. |
| Terzo Mondo. | Espressione che sottintende una classifica di superiorità/inferiorità. Al suo posto fare riferimento semplicemente all’area geografica. |
| Vu’ cumprà. | Termine dalle connotazioni negative. Non utilizzare. Quando riferito all’attività commerciale, sostituire con “venditore/ice”. |
| Zingaro/a/ə. | Termine stigmatizzante, che si riferisce alle “persone Rom e Sinti”. |
Fede e culto religioso
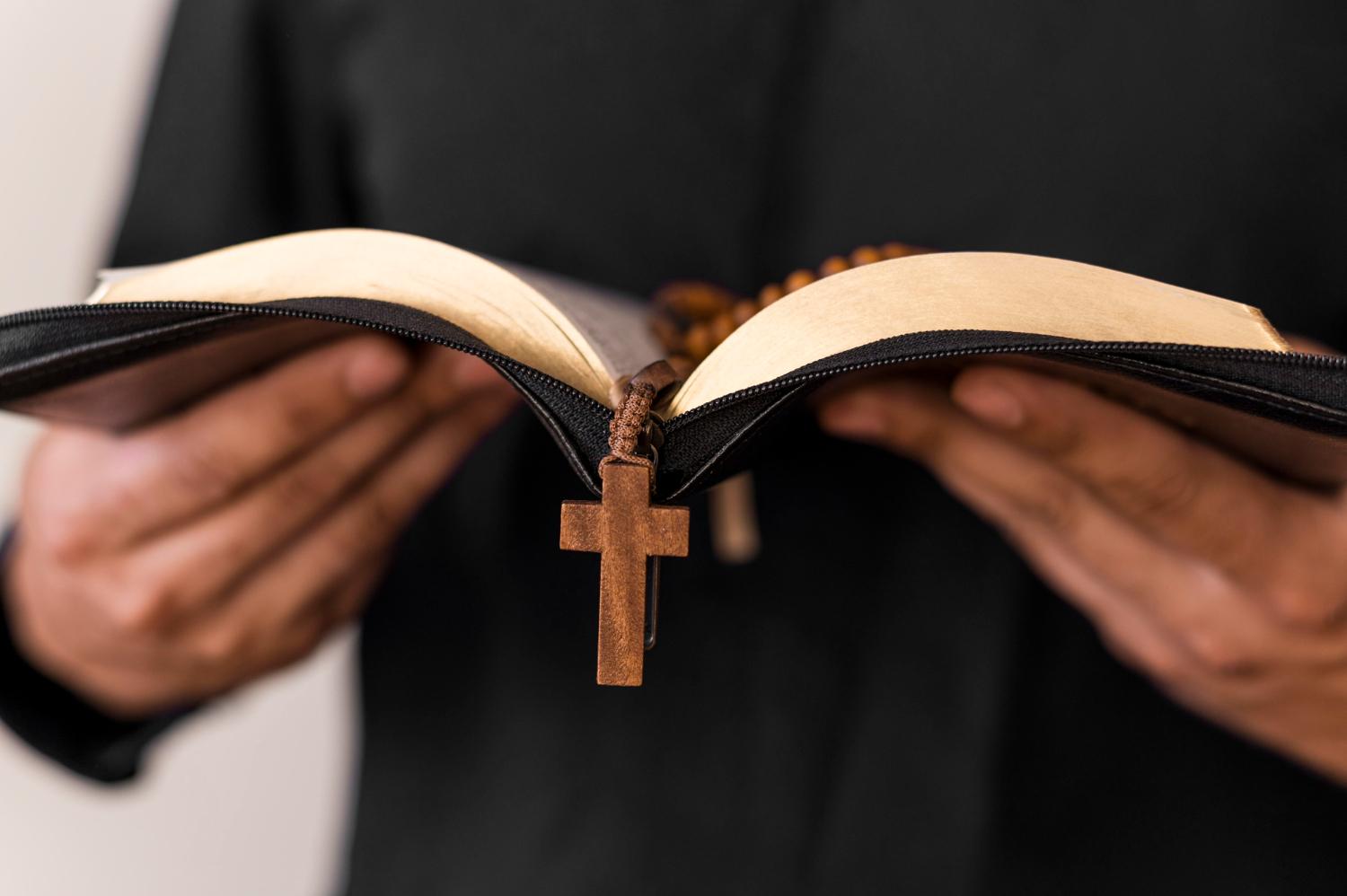
Definizione
La fede religiosa è un aspetto interiore e personale che riguarda la convinzione in una dimensione spirituale, una divinità, o un insieme di principi morali e spirituali. Si tratta di un atteggiamento di fiducia, credenza e devozione che una persona sviluppa verso una religione o un sistema di valori. La fede è quindi più soggettiva e non necessariamente legata a pratiche o rituali esterni.
Il culto religioso è invece l’aspetto esteriore e collettivo della pratica religiosa, che comprende i riti, le cerimonie, i simboli e le tradizioni utilizzati per esprimere la fede. È un modo attraverso cui una comunità religiosa manifesta pubblicamente la propria devozione a una divinità, a figure sacre, o a valori spirituali.
La fede religiosa è un fenomeno personale e spirituale, una credenza che può esistere anche senza manifestazioni esterne. Il culto religioso, al contrario, è la dimensione pubblica e rituale attraverso cui la fede viene espressa, celebrata e condivisa.
- La fede religiosa riguarda cosa si crede.
- Il culto religioso riguarda come si esprime ciò in cui si crede.
In questa sede, faremo riferimento prevalente al linguaggio che si può utilizzare per avere rispetto della fede di ciascuno, e di come riferirsi alle modalità di culto praticate.
Indicazioni generali
Riconoscere la diversità religiosa
Evitare di dare per scontato che tutti abbiano una fede religiosa o che appartengano a una religione specifica. Riconoscere l’esistenza di diverse fedi e della mancanza di fede (ateismo, agnosticismo, umanesimo).
Evitare stereotipi e pregiudizi
Non associare caratteristiche culturali o comportamenti a una determinata religione. Ad esempio, non presupporre che tutti i membri di una religione abbiano gli stessi valori o stili di vita.
Usare un linguaggio neutrale
Usare termini inclusivi come “festività” anziché “Natale” per includere celebrazioni religiose diverse. Oppure “luogo di culto” invece di riferirsi solo a “chiesa”, per includere sinagoghe, moschee, templi, ecc.
Chiedere con rispetto
Se necessario, chiedi in modo aperto e rispettoso informazioni sulle preferenze o sulle pratiche religiose di qualcuno, ma senza insistenza.
Adottare un tono neutrale nelle discussioni religiose
Evitare di fare commenti che potrebbero sminuire, criticare o promuovere una religione rispetto ad altre.
Considerare giorni e pratiche religiose
Nella pianificazione di eventi o attività, considera le festività religiose di diverse tradizioni e cerca di non sovrapporle.
Concetti essenziali
Usare neutri e inclusivi come fede invece di religione, quando si vuole includere anche chi ha un credo non religioso.
Usare nomi specifici per denominazioni o gruppi religiosi, solo quando necessario e appropriato. Ad esempio, musulmani o ebrei ortodossi solo se rilevante per il contesto.
Astenersi dal giudicare chi non professa una religione.
In sintesi
| Parole ed espressioni da evitare | Parole ed espressioni inclusive |
| Credenti di altre religioni. | Persone di fede diversa. |
| Riferirsi a Natale, Ramadan, o altre festività religiose specifiche. | Festività religiose (in generale).
“Buone feste”, “Buon anno nuovo” (con attenzione con le comunità cinesi che hanno un capodanno differente. |
| Chi non crede in Dio. | Persone non religiose o atei/agnostici. |
| Senza fede. | Non lo sapete. La persona potrebbe avere una fede tutta sua. |
| “Le religioni inseguono il perdono.” | “Molte tradizioni religiose e filosofiche enfatizzano il valore del perdono.” |
| “Le donne musulmane portano il velo.” | “Alcune donne musulmane scelgono di portare il velo, in base alle loro convinzioni personali.” |
| “Tutti crediamo in Dio”. Esclude chi non crede in Dio (atei, agnostici, umanisti) e chi appartiene a religioni che non includono il concetto di “Dio” (es. alcune tradizioni buddhiste).in Dio”. | Non è detto! |
| “Solo i cristiani celebrano il Natale”. Esclude altre tradizioni religiose o spirituali che potrebbero celebrare il periodo in modi diversi. | “Durante questo periodo si celebrano molte festività diverse, come il Natale e altre ricorrenze religiose o culturali.” |
| “Religione vera” o “Unica religione”. Implica che una religione sia superiore o più autentica rispetto alle altre, sminuendo la diversità di fedi. | “Tradizione religiosa” o “Fede personale.” |
| “Chi non prega è senza valori”. Associa automaticamente il concetto di moralità alla pratica religiosa, escludendo chi segue principi etici senza aderire a un culto. | “I valori personali possono derivare da molte fonti, religiose o meno”. |
| “La nostra società cristiana”. Presuppone che tutti condividano una religione specifica, ignorando la presenza di persone appartenenti a altre fedi o non religiose. | “La nostra società è composta da persone di diverse tradizioni religiose e non religiose.” |
Verso un linguaggio ampio
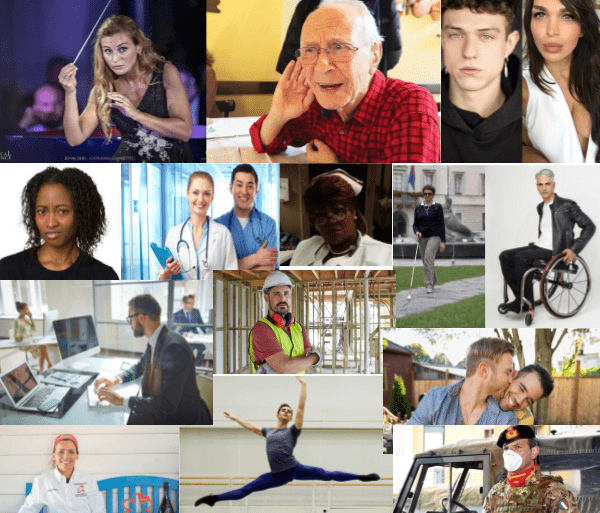
Il linguaggio “ampio” può rappresentare l’evoluzione del linguaggio “inclusivo. Esso può essere inteso come un tentativo di:
- integrare inclusività e naturalezza: Adottare una comunicazione fluida e comprensibile senza ricorrere a forme percepite come “costruite”.
- focalizzarsi sulla chiarezza: Preferire formulazioni che includano implicitamente tutti, ma senza appesantire il discorso (es. “il personale” anziché “le lavoratrici e i lavoratori”).
- promuovere flessibilità culturale: Includere riferimenti e modalità espressive che tengano conto delle diversità, ma che siano facilmente interpretabili da un pubblico ampio.
Perché un linguaggio ampio?
- Accessibilità: È più facilmente accettato e compreso da chi non è abituato al linguaggio inclusivo stretto.
- Universalità: Funziona meglio in contesti globali o eterogenei.
- Praticità: Riduce le controversie legate alle scelte stilistiche, rendendo il messaggio più chiaro.
In sintesi
| Situazione | Linguaggio inclusivo tradizionale | Linguaggio ampio |
| Riferimento al genere | “Care tutte e tutti” | “Ciao a tutte le persone” |
| Professioni | “Medici e mediche” | “Chi lavora in medicina” |
| Pronome neutro | “Lə studentə” | “Ogni studente” o “studenti” |

