Il pensiero comune e la sua evoluzione
Spesso si pensa che la non monogamia significhi semplicemente “avere più partner”. In realtà è un cambiamento più profondo: riguarda il modo in cui concepiamo l’amore e il valore delle relazioni.
Nel sistema monogamo tradizionale, c’è una gerarchia: la relazione romantico-sessuale viene messa al vertice, mentre amicizie, affetti familiari e altri legami vengono considerati “secondari”. Decostruire questa logica significa riconoscere che anche altre forme d’amore possono essere importanti, intime e significative.
Negli ultimi anni, il termine poliamore è entrato sempre più spesso nel linguaggio comune. Serie televisive, podcast e dibattiti online hanno portato all’attenzione pubblica un modo di vivere le relazioni che mette in discussione uno dei pilastri culturali dell’Occidente: la monogamia. Ma cosa significa davvero essere poliamorosi? È solo una “moda” o rappresenta un cambio profondo nel modo in cui concepiamo l’amore e la libertà affettiva?
Cos’è il Poliamore
Il poliamore è la possibilità di vivere più relazioni amorose e/o sessuali contemporaneamente, con il consenso e la consapevolezza di tutte le persone coinvolte. Il poliamore si distingue dalle relazioni extraconiugali o dal tradimento proprio perché è basato sulla trasparenza, la comunicazione e il consenso.
Esistono diverse forme di poliamore: da quello gerarchico, in cui una relazione “primaria” mantiene un ruolo prioritario, a quello non gerarchico, dove ogni legame ha pari dignità. Altri preferiscono vivere come solo poly, ossia persone che non desiderano convivere o condividere le finanze, ma coltivano relazioni multiple indipendenti.
In tutti i casi, il principio comune è che l’amore non è una risorsa finita e che l’affetto per una persona non sminuisce quello per un’altra.
Oltre la mononormatività
La nostra società è costruita su un paradigma chiamato mononormatività: l’idea che la monogamia sia l’unico modo “naturale”, sano e moralmente giusto di amare. Questo modello è così radicato che spesso non lo mettiamo neppure in discussione, proprio come i pesci della metafora di David Foster Wallace che nuotano senza sapere cos’è l’acqua.
La monogamia, però, non è un fatto biologico o universale: è una costruzione storica e culturale. Con la nascita del capitalismo e della famiglia borghese, la coppia monogama è diventata la cellula base della società: un’unità produttiva e riproduttiva utile a garantire stabilità economica, divisione dei ruoli di genere e controllo sociale.
In questo contesto, l’amore romantico è stato “romanticizzato” e idealizzato come collante emotivo, ma anche come meccanismo di conformità.
Il mito dell’amore romantico
L’amore romantico, nella sua versione più tradizionale, propone una visione esclusiva e totalizzante: una sola persona per colmare tutti i bisogni emotivi, sessuali, affettivi e materiali. Questo modello, oltre a essere spesso irrealistico, tende a produrre dinamiche di possesso, gelosia e dipendenza.
Il poliamore, al contrario, invita a una decentramento della coppia e a un ripensamento radicale dei legami. Non si tratta di “avere più partner”, ma di costruire relazioni basate sull’autenticità, sull’autonomia e sulla responsabilità condivisa. Non basta moltiplicare i partner per uscire dal paradigma monogamo: serve un vero cambio di mentalità, un’educazione affettiva che metta al centro la comunicazione, il consenso e il rispetto reciproco.
L’anarchia relazionale e le relazioni queerplatoniche
Tra le forme più radicali di non monogamia troviamo l’anarchia relazionale, una filosofia che rifiuta la gerarchia tra relazioni e valorizza ogni legame in base alla sua unicità, senza etichette preconfezionate. In questa prospettiva, anche l’amicizia, la famiglia scelta o le relazioni queerplatoniche, connessioni emotive profonde non romantiche né sessuali, possono avere la stessa importanza di un rapporto amoroso.
Queste esperienze ci invitano a ripensare la rete affettiva come un ecosistema complesso, dove ogni persona contribuisce in modo diverso al nostro benessere emotivo. Non c’è una scala di valori predefinita tra “amore vero” e “semplice amicizia”: esistono solo connessioni significative, negoziate e vissute in modo consapevole.
Sfide e pregiudizi
Vivere il poliamore oggi significa anche confrontarsi con molti pregiudizi sociali. Le persone non monogame vengono spesso accusate di essere incapaci di impegnarsi, promiscue o immature. Nella realtà, la gestione di più relazioni richiede un enorme lavoro di comunicazione, trasparenza e cura. Inoltre, molte teorie psicologiche e pratiche terapeutiche continuano a portare un forte bias mononormativo, che rischia di patologizzare la non monogamia.
Decostruire, non sostituire
Il poliamore non è un modello superiore, ma un’alternativa possibile. Il suo scopo non è cancellare la monogamia, bensì ampliare lo spettro delle scelte relazionali. In un mondo in cui la libertà individuale è spesso celebrata solo a parole, il poliamore propone una pratica concreta di autodeterminazione affettiva: costruire relazioni su misura, negoziare i confini, e imparare che la cura può essere collettiva, non esclusiva.
Per concludere
Il poliamore è, in ultima analisi, una pratica di consapevolezza. Ci invita a chiederci cosa desideriamo davvero, quali aspettative ereditiamo dalla cultura, e come possiamo amare in modo più etico e libero.
Che si scelga la monogamia o il poliamore, l’obiettivo è lo stesso: creare legami basati sul rispetto, sulla comunicazione e sull’onestà. Come scrive l’autrice Brigitte Vasallo, “non si tratta di quanti amori viviamo, ma di quanto amore siamo capaci di costruire insieme”.
Un suggerimento di lettura
Suggerisco vivamente la lettura de “La zoccola etica” di cui riporto una breve presentazione.
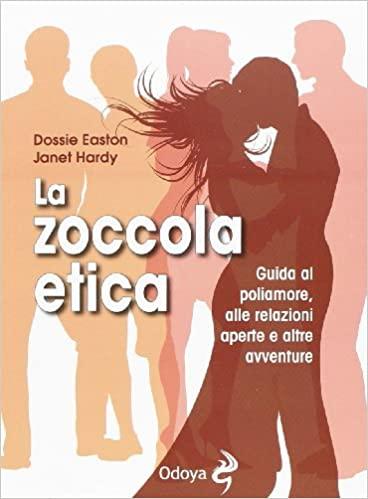 La zoccola etica di Carlotta Vagnoli è un saggio che esplora il concetto di libertà sessuale femminile, smontando stereotipi e pregiudizi legati al desiderio e all’autonomia delle donne. Con uno stile diretto e consapevole, l’autrice invita a riflettere su consenso, rispetto e autodeterminazione. È un testo che unisce impegno femminista e introspezione personale, promuovendo un’etica del piacere libera da giudizi.
La zoccola etica di Carlotta Vagnoli è un saggio che esplora il concetto di libertà sessuale femminile, smontando stereotipi e pregiudizi legati al desiderio e all’autonomia delle donne. Con uno stile diretto e consapevole, l’autrice invita a riflettere su consenso, rispetto e autodeterminazione. È un testo che unisce impegno femminista e introspezione personale, promuovendo un’etica del piacere libera da giudizi.


